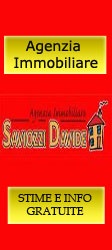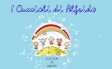Il mese scorso è stato presentato un nuovo libro pubblicato dall'Editore MdS, "Il coraggio tra i fiori di ortica", un'opera intensa e profonda cheracconta l'infanzia non solo nella sua dimensione più luminosa, ma anche nelle sue ombre, fatta di giochi e risate, ma anche nelle sue ombre, tra segreti, paure, abusi e battaglie quotidiane che i più piccoli affrontano con straordinaria forza.
Un libro che ci ha subito colpito e per il quale si preannunciava un sicuro interessamento e successo a livello nazionale.













-
FESTA DELLA MAMMA "Essere madre: forza, realtà e consapevolezza" [1]
-
LA DIFESA EUROPEA. [1]
-
“Costruire ponti è quello che serve in questo momento storico” [1]
-
Invito a scrivere per la festa della mamma [3]
-
Scritto a “fagiolo”! [2]
-
Che vita da cani! [3]
-
Questo giovane di soli 22 anni è stato rapito dai miliziani di Hamas, torturato e ucciso. [3]


di Valdo Mori











mi affiorano i ricordi.
La tua testimonianza,
mamma carissima,
e non la donna
cinica e prepotente
ormai assente
e così .....
ora anche tir, pulman turistici , trattori, camion con cassoni per massi,
etc. . E ad alta velocita,
inquinamento .....



-
Stanziati 600.000 euro per la sistemazione del fosso e della strada a Via Turati, Arena Metato [484]
-
Partito il servizio ecomobile [263]
-
Che vita da cani! [190]
-
MARCIA TRIONFALE DEL MIGLIARINO/VECCHIANO PER RITROVARE LA PRIMA CATEGORIA. VINCE LA FINALE DI GIRONE "A" [163]
-
Invito a scrivere per la festa della mamma [156]
-
"In principio era il caos e alla fine.. Pure!" [135]
-
Opportunità di lavoro e formazione: arrivano gli Open Day di Copernico [128]
-
"Un Tè in Casa MdS" con Maurizio Gazzarri [125]
-
NELLA TERRA DEI CACHI. [116]
-
MOSTRA BICI DA CORSA Domenica 11 maggio [112]
-
IL PISA CALCIO IN SERIE "A". 34 ANNI CHE NON SI SCRIVEVA. FILIPPO INZAGHI SIGNORE DEL CALCIO C'HA CREDUTO [109]
-
JOBS ACT O NON JOBS ACT ? LAVORATORI SUL BINARIO MORTO. [105]
-
Flora Tristan una donna speciale quasi dei tempi nostri [103]
-
Scritto a “fagiolo”! [102]
-
🟠Allerta meteo #arancio in arrivo- dalle 08.00 di lunedì 5 maggio alle 23.59 dello stesso giorno; [98]
e
Oenanthe oenanthe

Oggi mi sento “prof”, oggi e basta però, altre volte diavoletto e altre, le più, contorto!
E qui, a proposito di contorsioni, ce ne sono a volontà ma non dovute a me.
Cominciamo dal primo Oenanthe, anzi prima, quella crocata.
Tutta colpa di Linneo, sia chiaro!
Oenanthe è parola greca formata da oinos ed anthos (vino e fiore), nome scelto dal grande scienziato perché se la pianta veniva ingerita, anche in piccole dosi, dava all’uomo una sensazione di ubriachezza.
Comprensibile facilmente, ma arriviamo al genere: crocata.
Lo zafferano è giallo, deriva dal crocus, e giallo nella pianta è il succo che si ricava dalla radice e qui si va sul macabro.
La pianta è chiamata finocchio d’acqua, ma un tempo era detta erba sardonica dato che era presente solamente in Sardegna, niente di strano quindi se non la derivazione dell’aggettivo spostato al ghigno che vediamo nei musei sardi sulle maschere funebri o quelle terrificanti del teatro greco.
Altro che ubriachezza!
Nell’antica civiltà nuragica ai vecchi inutili veniva dato da bere il succo dell’erba e la morte sopraggiungeva velocemente facendo contrarre i muscoli facciali in una smorfia, un falso sorriso, detto appunto “sardonico”!
Ora l’erba sardonica, l’Oenanthe crocata, è presente in diversi straordinari esemplari, alti oltre un metro e mezzo dal pelo dell’acqua, nelle zone umide del nostro Parco delle meraviglie, sicure di non far danni (ora menomale c’è la Società della salute!).
Eccoci ora al secondo Oenanthe, con la specie simile al genere e così si elimina una spiegazione sull’etimologia.
Questo è un uccellino, bellino bellino, non morde, non fa danni ed è molto buono in un arrostino: il culbianco.
Santoddio Linneo, eri senz’idee? e ora come la mettiamo con la spiegazione?
Non riesco proprio a capire e devo, dobbiamo, prendere per buona quella di un studioso spagnolo che la fa derivare dalla migrazione che il culbianco fa in Grecia(?) durante la fioritura della vite.
Dobbiamo aver fede!
 INSERISCI IL TUO COMMENTO
INSERISCI IL TUO COMMENTO29/5/2018 - 19:26
AUTORE:C'è del contorto nell'aria.
Manca il culbianco, ma d'altra parte c'era solo il suo nome nell'articolo, quel nome che Linneo aveva dato a due generi completamente diversi: una pianta e un uccello...strano davvero! Ed è questa stranezza che volevo rimarcare.
L'uccellino era solo un pretesto per far notare certe attribuzioni date con la più grande fantasia e altrettanto grande curiosità.
"A me mi" garba tanto quel grande svedese!
grazie per la curiosità Cloe.
29/5/2018 - 18:30
AUTORE:28/5/2018 - 22:04
AUTORE:solo in Sardegna?
e qui allora?