
Evento davvero memorabile a san Giuliano Terme il 25 luglio a partire dalle ore 18, all'interno del Fuori Festival di Montepisano Art Festival 2024, manifestazione che coinvolge i Comuni del Lungomonte pisano, da Buti a Vecchiano."L'idea è nata a partire dalla pubblicazione da parte di MdS Editore di uno straordinario volume su Puccini - spiega Sandro Petri, presidente dell'Associazione La Voce del Serchio - scritto da un importante interprete delle sue opere, Delfo Menicucci, tenore famoso in tutto il mondo, studioso di tecnica vocale e tante altre cose.














-
Renzi: "Se cade il governo, subito al voto. Attrezziamoci per vincere". Zingaretti: "Bene la svolta" [2]
-
Il centrosinistra. [15]
-
Grande Nino! [1]
-
Con noi nel centrosinistra si rafforzare l'ala riformista [2]
-
Premesso... [1]
-
Punti e posti di vista. [3]
-
Vecchiano e i ritardi dei consigli comunali rimandati “i consiglieri di opposizione chiedono un cambio di passo” [3]

di Valdo Mori


di Valdo Mori










Da dopo la Conad ci sono ancora i 50km/ h fino .....



-
Cronaca di un pomeriggio pucciniano e di una serata musicale [202]
-
Vecchiano e i ritardi dei consigli comunali rimandati “i consiglieri di opposizione chiedono un cambio di passo” [196]
-
Punti e posti di vista. [150]
-
Aperte le Iscrizioni per la Formazione di Volontariato all'Ass. Oncologica Pisana "P. Trivella " [149]
-
Il centrosinistra. [139]
-
Verso sempre nuovi orizzonti [133]
-
Marina Folk Festival [124]
-
Il salvataggio del biacco. [122]
-
Renzi: "Se cade il governo, subito al voto. Attrezziamoci per vincere". Zingaretti: "Bene la svolta" [110]
-
Dualiber al Giardino La Nunziatina Bossa nova, jazz e i successi anni '60 [107]
-
La guerra cognitiva russa contro l’Occidente. Intervista a Luigi Sergio Germani [105]
-
I riformisti. Il tempo delle scelte [103]
-
Romanzina Quirinale - Mattarella prova a spegnere sul nascere le aspirazioni trumpiane di Meloni [102]
-
Mattarella in Brasile: italiano tra gli italiani a 150 anni dall’emigrazione tricolore [100]
-
Grande Nino! [99]
Gli emendamenti alla proposta Casellati-Meloni. Alcune domande al prof. Carlo Fusaro
Gli emendamenti del Governo alla propria proposta Casellati-Meloni conservano la legittimazione diretta del Presidente del consiglio, nella fattispecie dell’elezione diretta, con la previsione di votazione di fiducia iniziale che questi deve chiedere al Parlamento per il suo governo. Gli emendamenti mantengono la figura del secondo Presidente del consiglio, espresso dalla coalizione vincitrice delle elezioni, che si attiverebbe in caso di “morte, impedimento permanente, decadenza o dimissioni volontarie” del premier.
Secondo le critiche di vari costituzionalisti, quest’ultima figura del secondo premier – non eletto – avrebbe una forza maggiore del primo – eletto direttamente – in quanto non sostituibile, pena lo scioglimento delle Camere. Nonostante gli emendamenti, non risulta chiara la disciplina della sfiducia (nei casi di mozione di sfiducia, di bocciatura come esito della questione di fiducia posta dal governo, di dimissioni di iniziativa del presidente del consiglio), come pure non appare chiara la definizione dei poteri del premier.
Prof. Fusaro, qual è il suo giudizio su questi punti cruciali?
Premetto di essere favorevole a un’applicazione piuttosto rigida del meccanismo c.d. simul simul: in casi diversi da morte, impedimento permanente o decadenza, sarei per lo scioglimento. Si potrebbe immaginare un’eccezione: un governo di emergenza nazionale, affidato al primo ministro eletto o comunque da lui accettato in alternativa allo scioglimento, purché sostenuto da una maggioranza qualificata (anche il 60%: a garanzia che il grosso della maggioranza eletta con lui ne sia parte). Altrimenti anche i costituzionalisti devono mettersi d’accordo con sé stessi. Mi spiego: se si vuole un’attenuazione più ampia della rigidità del simul simul è evidente che si deve permettere un altro premier; se si permette un altro premier (una forzatura rispetto all’elezione diretta!) è ragionevole si pongano dei limiti, se no si apre ad ogni sorta di pasticcio (tipo la legislatura del 1996: tutta governata dal centro-sinistra ma con quattro governi e tre premier: Prodi, D’Alema, Amato). D’altra parte, rispetto alla formula che sarebbe stata escogitata da Calderoli nell’emendamento di maggioranza, va detto che i casi di voto contrario sulla questione di fiducia posta dal governo sono stati due (due) in 75 anni. Comunque a scanso di equivoci e a disincentivare pastrocchi l’ideale sarebbe sopprimere l’aggettivo “volontarie”. L’ha proposto un esimio costituzionalista favorevole alla riforma, l’ex giudice costituzionale Nicolò Zanon e io sono d’accordo con lui.
Quali altri istituti del testo governativo sono stati modificati dagli emendamenti, e come li giudica?
L’introduzione del limite di mandato, l’attribuzione al premier di revoca oltre che nomina dei ministri (nei termini di proposte al presidente della Repubblica sostanzialmente vincolanti, salvo casi eccezionali), la riscrittura dei riferimenti alla legge elettorale e l’attribuzione al premier del potere di fatto di scioglimento, salvo il caso di cui s’è detto sopra: tutti miglioramenti utili, nella direzione suggerita da molti studiosi e critici non aprioristici del progetto.
Non mi domanda cosa NON è stato modificato: per esempio la previsione di una fiducia iniziale al Governo. Non ne farei una questione di vita o di morte, ma indubbiamente mi pare che strida non poco con l’elezione diretta (se non anche con l’indicazione sulla scheda) del presidente del Consiglio. Sta a significare che i gruppi parlamentari di maggioranza si riservano di infliggere un’umiliazione all’eletto nel caso non piaccia loro la composizione del Governo (come dire, nel caso in cui siano scontenti dei ministri ottenuti o non ottenuti). Siccome il testo prevede un esame di riparazione per il premier eletto (che può ripresentarsi alle Camere), il rischio è di avere un premier legittimato dal corpo elettorale ma indebolito e delegittimato dai partiti della sua stessa maggioranza in Parlamento: un rischio che io eviterei.
E riguardo agli emendamenti presentati dalle forze politiche di opposizione?
Distinguerei cinque tipi di emendamenti. (A) Quelli ostruzionistici (i 1800 dei gruppi PD e Alleanza Verdi-Sinistra), che è inutile commentare; (B) quelli, sempre di Alleanza Verdi-Sinistra, che sostanzialmente ripropongono con modifiche minori la forma di governo vigente; (C) quelli “veri” del PD (sarebbero una dozzina per dichiarazione del senatore Alfieri), del M5S, di Azione che vanno (con diversi livelli di rigore e coerenza) sostanzialmente nella direzione di un modello alternativo di più lieve rafforzamento “alla tedesca” della forma di governo; (D) quelli di Italia Viva che cercano di trasformare il progetto del governo AS935 in quello da essa presentato AS830 (c.d. sindaco d’Italia); (E) quelli un po’ di tutti i gruppi che mirano ad allargare l’ambito della riforma a tematiche da essa non affrontate: estensione delle funzione del Parlamento in seduta comune, riforma del Senato, regolamentazione più stringente della decretazione d’urgenza, voto a data certa per iniziative del governo, disciplina dei partiti politici, potere di rinvio del presidente della Repubblica, quorum del referendum abrogativo, parità di genere nella composizione del governo.
Un eventuale referendum sulla proposta governativa rischierebbe di essere devastante, in quanto giocherebbe sulla contrapposizione tra governo e attuale opposizione, tralasciando i contenuti della riforma. Ritiene questo rischio fondato?
Io penso che con un minimo di buona volontà da un punto di vista tecnico un ampio consenso dovrebbe poter essere raggiunto. E ci sono associazioni e gruppi anche di opposizione che spingono in tal senso (per esempio LibertàEguale). Bisogna vedere se ci sarà, magari dopo le elezioni europee, la volontà politica (questo è più difficile). Sarebbe utile perché questo tipo di riforme dovrebbero essere condivise (anche ad evitare che ogni maggioranza faccia la propria riforma ogni volta che va al potere). Ciò detto, l’aggettivo devastante mi sembra esagerato. Diciamo che il referendum (che vedo tuttora molto probabile perché un quinto dei membri di una Camera, il 20% sono solo 80 deputati e 40 senatori, si troverà quasi certamente) potrebbe come lei dice, visti i precedenti, trasformarsi in un referendum su Meloni (come quello del 2016 divenne un referendum su Renzi).
Siccome non si sa come possa poi andare, dovrebbe essere nell’interesse sia della maggioranza sia delle opposizioni evitarlo. Continuo a sperare, ma è l’ottimismo della volontà, non quello della ragione.





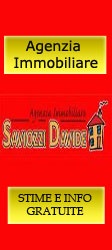



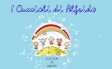


 INSERISCI IL TUO COMMENTO
INSERISCI IL TUO COMMENTO