
Il mese scorso è stato presentato un nuovo libro pubblicato dall'Editore MdS, "Il coraggio tra i fiori di ortica", un'opera intensa e profonda cheracconta l'infanzia non solo nella sua dimensione più luminosa, ma anche nelle sue ombre, fatta di giochi e risate, ma anche nelle sue ombre, tra segreti, paure, abusi e battaglie quotidiane che i più piccoli affrontano con straordinaria forza.
Un libro che ci ha subito colpito e per il quale si preannunciava un sicuro interessamento e successo a livello nazionale.













-
Risposta fotografica e scritta [3]
-
25 aprile 2025 [4]
-
BOBINA DI TESLA IN AGRIFIERA 2.000.000 di Volt [1]
-
Ma che banda! [3]
-
L'Annunziata (Lucia) ha detto una frase che credo superi qualsiasi caxxata lei abbia mai pronunciato [2]
-
Oggi e i colori. [2]
-
ANCHE A PASQUA SI APRONO GLI STADI. SI GIOCA ANCHE LA SERA DEL SABATO SANTO E LEGGETE LA CITTA' CHE GIOCA [4]


di Valdo Mori











Ma è inevitabile
Chiudo gli occhi per non guardare
Ma quella livida rigidità
appare scompare riappare
Io ti .....
ora anche tir, pulman turistici , trattori, camion con cassoni per massi,
etc. . E ad alta velocita,
inquinamento .....



-
In seconda categoria Il Migliarino/Vecchiano ai play off. Domenica 27 ore 16,00 in casa vs San Vitale Candia [169]
-
L'Annunziata (Lucia) ha detto una frase che credo superi qualsiasi caxxata lei abbia mai pronunciato [162]
-
Agrifiera 2025 è qui! Vi aspettiamo dal 23 aprile al 4 maggio [156]
-
Transizione ecologica non vuol dire devastazione del territorio. [155]
-
Ma che banda! [148]
-
Oggi e i colori. [132]
-
Petalo bianco-L’illusione degli anti Meloni di acchiappare voti con un partitino cattolico [132]
-
Liberazione: le celebrazioni a San Giuliano Terme [120]
-
Insediamento nuovo parroco parrocchia San Frediano in vecchiano [119]
-
Massimo Cacciari attacca Elly Schlein: " Il 25 Aprile? La sinistra di ogginon ha nulla a che vedere con la Resistenza" [119]
-
"AVERNO" LIBRO DI ALDO DEL GRATTA 28 APRILE ORE 17,00 AGRIFIERA PONTASSERCHIO [109]
-
1° Maggio festa del lavoro – Spazio Donna per il lavoro invisibile [107]
-
#80esimodellaLiberazione #25Aprile [95]
-
Lasciate perdere tutti coloro che hanno fatto la lista di chi non doveva esserci. [93]
-
Celebrata la Liberazione al monumento dell'eccidio della Romagna [87]
Come eravamo: durante le feste patronali dei paesi, uno dei “dolci” più richiesti dai bambini era la “collanina” delle niccioline (che non erano quelle tostate dette americane).
Per chi aveva più figli questuanti e piagnucolenti, o non abbastanza soldi in tasca, c’era l’opportunità di ripiegare sui braccialetti fatti con le stesse nocciole e che costavano meno. Ci si accontentava comunque.
Le Nocciole e la loro festa
Uno gli alberi più antichi del pianeta, il nocciolo, arriva in Europa dall’Asia nel periodo tra gli 8000 ed i 5500 anni a.C. subito dopo il disgelo del periodo glaciale.
Albero nobile al punto da rientrare in molte credenze magiche e mitologiche, è stato associato al soprannaturale, mentre i suoi frutti erano cibo sacro secondo alcune religioni asiatiche, rimedi contro i morsi velenosi secondo i Greci, legati alla fecondità secondo altri e addirittura simboli di pace per i Romani.
Prima di proseguire, sgombriamo un dubbio. Pensare di mangiare frutta secca, parlando delle nocciole, è parzialmente sbagliato. La nocciola, infatti, è l’insieme del guscio e del suo contenuto. Ciò che consumiamo, invece, è solo il seme, cosa ben diversa.
Una vecchia leggenda sostiene che un viandante furbo, per ingraziarsi gli Dei, promise di fare a metà di tutto quello che avrebbe trovato durante il viaggio. Quando trovò un sacco di nocciole, mantenne la promessa dando i gusci agli Dei e tenendo i semi per sé.
In Italia le nocciole si mangiano a tavola a chiusura del pasto, soprattutto nei mesi invernali. A seconda dei gusti, possono essere acerbe, di un colore tendente al verdolino, ottime secondo alcuni, mature o a diversi livelli di tostatura. In molti paesi meridionali le nocciole sono l’immancabile chiusura del pranzo serale di tutto il periodo natalizio.
Si usavano anche come gioco: tre nocciole a triangolo, una nocciola sopra e da lontano si lanciava per cercare di abbattere il “castelletto”. Chi vinceva prendeva tutto. Un altro gioco consisteva nel lanciare una nocciola tentando di avvicinarsi il più possibile ad un muro. Ancora una volta, chi ci riusciva “era tutto suo”. Poi si mangiavano tutte, tenendo quelle più pesanti, ritenute meglio manovrabili in questi giochi.
Sotto forma di Nutella ed altre creme con e senza cioccolato ,oppure come ingrediente fondamentale dei celebri cioccolatini gianduiotti, la nocciola incontra i favori di moltissimi che la prediligono anche in altri tipi di dolci, biscotti, torte e crepes. Come granulato, inoltre, è presente su gelati, dolci flambè, banane fritte e molti altri dessert.
In cucina si usa in molti piatti. Sotto forma di olio è uno splendido condimento a crudo per il pesce. Frantumata è ottima su zuppe ristrette di fagioli e riso, in intingoli per la carne, come ingrediente secondario di insalate.
La Festa delle nocelle
In qualche regione d’Italia ricorrevano alcune feste primaverili che avevano più di un addentellato con quelle che si celebravano in antico: una delle più caratteristiche, se pur fra le meno conosciute, era la cosiddetta fFesta delle nocelle" che aveva luogo ogni anno nella pineta di Viareggio, il giorno successivo alla Santa Pasqua, ossia il giorno detto del pellegrino.
Già dalla sera precedente i venditori di cibarie rizzavano le loro tende nei punti strategici di passaggio, che si affrettavano ad accaparrarsi con il diritto del primo occupante. Alle prime ore del mattino del Lunedì di Pasqua, sotto i vecchi pini, l’allineamento era completo.
I ritardatari in seconda fila!
Ai primi raggi del sole arrivano donne con involti affardellati, bambini carichi di cerchi di legno e palle di gomma.
Si pranza fuori oggi: non proprio in trattoria, ma forse anche meglio.
La sposa ha pensato a tutto, i ragazzi si divertono e il marito può arrivare alle dodici in punto che “il pranzo è servito”.
I bambini, già esperti boscaioli, chiedono alla mamma di accamparsi vicino a due pini ai quali possono legare la pisalanca, come era detta in dialetto viareggino l’altalena da noi pisani chiamata invece penduligiana.
Il soffice tappeto degli aguglioli fa da materasso e non ci sono pericoli.
Verso le undici è tutto uno sfarfallio di pisalanche da un capo all’altro della pineta e i vestitini colorati dei bambini, che appaiono e scompaiono fra i tronchi dei pini, danno un senso di sbandieramento per quella giornata particolare.
Ma ecco che passano le venditrici di nocciole avellane, la principale attrattiva della fiera, che da esse ha preso il nome.
“Belle nocciole! Nocelle! Nocelleee!”
Allora tutte le altalene si fermano, e si sente una voce sola:
“Mamma me le compri?”
Va detto che le nocciole erano vendute in moltissime feste, ma in forma sciolta come i semi di zucca, le seme, ma solamente in Versilia e nelle feste apuane, era invalsa la moda delle collane di questi frutti.
Questo recava un certo disagio fra le mamme e contesa fra i figli perché “la collana” non era distribuibile senza romperla e farle perder il fascino che aveva e neanche comprarne più di una che i soldi eran pochi.
Le nocciolaie versiliesi, quasi tutte native di Massa o dei paesi circonvicini, avevano molto dello zingaresco, sia per la carnagione abbrustolita dal sole, sia per il colore dei loro abiti e dei loro scialli. Se ve ne era una con le scarpette bianche, diversamente dalle altre che avevano ciabatte a piedi nudi, veniva subito fatto notare, malignamente, che quelle erano scarpette di tela gommata che il marito, forse bagnino, aveva trovato alla fine della stagione balneare dell’anno precedente.
Festa perduta di primavera, festa dei bambini, festa della Natura che germoglia eternamente fra le piante e fra gli uomini.
Un’ultima annotazione: quello delle nocciolaie era un lavoro duro e saltuario, ma dava senz’altro da guadagnare se nel cimitero monumentale di Staglieno, a Genova, esiste una mirabile statua di una “venditrice di noccioline” che ha scolpito in basso una scritta in genovese così tradotta:
“A forza di vendere collane di noccioline e dolci all'Acquasanta, al Garbo, a San Cipriano, con vento e sole, con acqua giù a secchi, alla mia vecchiaia per assicurarmi un pane; fra i pochi soldi, mi ammucchiavo quelli per tramandarmi al tempo più lontano, mentre son viva, da vera abitante di Portoria: Caterina Campodonico (la Paesana) -1881- da questa mia memoria, se vi piace, voialtri che passate, pregatemi pace."




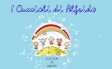


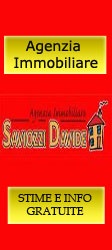





 INSERISCI IL TUO COMMENTO
INSERISCI IL TUO COMMENTO